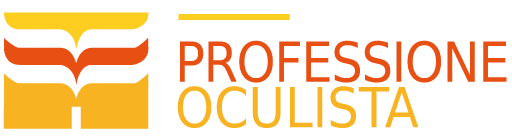Il valore clinico dell’esame refrattivo
L’esame refrattivo è il cuore della pratica clinica oculistica e ortottica.
Non si tratta soltanto di stabilire quale lente correttiva adottare, ma di compiere un percorso metodico e strutturato che tenga conto delle esigenze specifiche del paziente, della sua età, delle sue abitudini visive e dell’ambiente in cui vive e lavora.
Un esame condotto con accuratezza garantisce non solo una migliore qualità visiva, ma anche un impatto positivo sulla postura, sulla concentrazione e sulla vita quotidiana del paziente.
Al contrario, errori di metodo o valutazioni affrettate possono portare a prescrizioni inadeguate, con conseguenti disagi e riduzione del benessere visivo.
L’importanza dell’anamnesi nell’esame refrattivo
Ogni esame refrattivo inizia con un dialogo. L’anamnesi è il momento in cui il professionista crea un rapporto di fiducia con il paziente e raccoglie informazioni preziose che guideranno tutto il percorso successivo.
Durante questa fase si esplorano il motivo principale della visita, la natura e la frequenza dei sintomi percepiti, le abitudini lavorative e di studio, le attività sportive e ricreative, oltre alla storia sanitaria personale e familiare.
È importante prestare attenzione non solo a ciò che il paziente racconta, ma anche al modo in cui lo racconta, cogliendo eventuali esitazioni o dettagli che possono rivelare aspetti non immediatamente evidenti.
Gli esempi clinici dimostrano quanto questo passaggio sia fondamentale: un ipermetrope non corretto può accusare mal di testa ricorrenti e difficoltà di concentrazione durante lo studio; un guidatore notturno può sviluppare sdoppiamenti visivi che compromettono la sicurezza alla guida; un atleta, invece, può soffrire di difficoltà nei movimenti saccadici o nell’inseguimento visivo, con ripercussioni sulla performance sportiva.
Anche le patologie sistemiche hanno un ruolo determinante.
Malattie come diabete, ipertensione o sclerosi multipla, così come alcune terapie farmacologiche, possono influenzare la funzione visiva e generare disturbi specifici.
Allo stesso modo, una familiarità per patologie oculari consente di anticipare possibili problematiche e di orientare con maggiore precisione i test da eseguire.
In questo senso, dettagli che potrebbero sembrare marginali diventano fondamentali: l’anamnesi non è un semplice preludio all’esame, ma rappresenta il primo strumento diagnostico per definire una valutazione personalizzata e realmente efficace.
Esame obiettivo generale: visione e postura
La valutazione obiettiva del paziente non riguarda solo gli occhi.
Visione e postura, infatti, sono strettamente collegate: difetti refrattivi e strabismi possono indurre compensazioni inconsapevoli, come la rotazione della testa per migliorare la messa a fuoco o contratture di collo e spalle dovute a uno sforzo visivo eccessivo.
Osservare attentamente la posizione del capo, l’allineamento delle spalle o i segni di affaticamento visivo consente di cogliere elementi importanti per una diagnosi completa e per una prescrizione realmente efficace.
Test oggettivi: le basi della refrazione
I test oggettivi costituiscono il punto di partenza per l’esame refrattivo, perché permettono di ottenere una misura iniziale indipendente dalla collaborazione del paziente.
Nonostante siano spesso rapidi, rappresentano un riferimento fondamentale su cui costruire la valutazione successiva.
L’autorefrattometria, ad esempio, consente in pochi secondi di stimare i difetti refrattivi attraverso l’analisi della luce riflessa dalla retina.
È un metodo veloce e preciso, ma può essere influenzato dall’accomodazione o risultare meno affidabile in presenza di opacità corneali o instabilità di fissazione.
La schiascopia, al contrario, richiede maggiore esperienza da parte dell’operatore, ma offre informazioni preziose e risulta particolarmente utile nei bambini o nei pazienti poco collaboranti, soprattutto se eseguita in cicloplegia.
Infine, la cheratometria misura la curvatura corneale e consente di individuare astigmatismi regolari e irregolari, oltre a rivelare anomalie strutturali come il cheratocono in fase conclamata.
Questi strumenti non vanno considerati come alternative isolate, ma come parti di un percorso integrato.
L’autorefrattometria fornisce una base rapida, la schiascopia conferma e affina i dati soprattutto in età pediatrica, mentre la cheratometria arricchisce il quadro con informazioni sulla superficie corneale.
Solo la combinazione di queste misurazioni permette al professionista di disporre di dati affidabili e di procedere con maggiore sicurezza alla fase soggettiva dell’esame.
Il ruolo centrale dell’accomodazione
L’accomodazione è il meccanismo che permette all’occhio di mettere a fuoco a distanze diverse. Con l’età questa capacità diminuisce, portando alla presbiopia.
In clinica è importante valutarne non solo l’ampiezza, ossia l’intervallo tra punto remoto e punto prossimo di visione nitida, ma anche la flessibilità, che riflette la capacità di passare rapidamente dal vicino al lontano, e il tono accomodativo, che non è mai completamente assente.
Le anomalie sono numerose: dall’eccesso allo spasmo, fino all’insufficienza, all’inerzia, alla fatica e alla paralisi.
Sono condizioni sempre più frequenti nei soggetti che utilizzano dispositivi digitali per molte ore al giorno e riconoscerle è fondamentale per proporre la correzione più adatta.
Test soggettivi: il feedback del paziente
Nessun esame refrattivo può dirsi completo senza il coinvolgimento diretto del paziente. Il momento soggettivo è quello in cui la percezione individuale diventa parte integrante della valutazione clinica:
solo attraverso il riscontro del paziente è possibile calibrare la prescrizione, affinando la correzione fino a garantire non solo nitidezza, ma anche un reale comfort visivo nella vita quotidiana.
Il test dell’annebbiamento permette di rilassare l’accomodazione e ottenere una rifrazione statica più attendibile.
Le tavole astigmatiche, invece, consentono di individuare e affinare l’asse dell’astigmatismo, mentre il test bicromatico rosso-verde sfrutta il fenomeno dell’aberrazione cromatica per bilanciare in modo preciso la correzione di miopia e ipermetropia.
Con i cilindri crociati è possibile perfezionare sia l’asse sia il potere della correzione astigmatica, arrivando a una definizione molto accurata.
Infine, il test del bilanciamento ha il compito di verificare l’armonia binoculare tra i due occhi, assicurando che la correzione risulti equilibrata e ben tollerata nel tempo.
In questo modo, il paziente diventa parte attiva del processo diagnostico e la prescrizione finale non è soltanto il risultato di dati strumentali, ma l’esito di un percorso condiviso e personalizzato.
Test aggiuntivi e anisometropia
Oltre ai test standard, esistono esami aggiuntivi che permettono di indagare aspetti più specifici della funzione visiva, come la motilità oculare, la fusione binoculare e la dominanza oculare.
Questi approfondimenti si rivelano spesso decisivi nei casi in cui la sola valutazione del visus non sia sufficiente a spiegare i disturbi riferiti dal paziente.
Un esempio particolarmente rilevante è rappresentato dall’anisometropia, cioè la differenza di rifrazione tra i due occhi.
Quando questa variazione è lieve può passare inosservata, ma se supera le quattro diottrie diventa quasi impossibile ottenere una fusione sensoriale stabile.
Il paziente può allora percepire immagini confuse, sdoppiamenti o una costante difficoltà di adattamento alle lenti.
In situazioni simili, il test della dominanza oculare diventa uno strumento prezioso: permette di individuare quale dei due occhi fornisce l’input visivo più affidabile e deve quindi essere privilegiato nella correzione.
Questo approccio, anche se comporta il sacrificio parziale dell’altro occhio, consente di raggiungere un miglior equilibrio e un comfort visivo più stabile nella quotidianità.
Esame refrattivo: un percorso complesso per un risultato semplice
Un esame refrattivo efficace non si limita a stabilire un valore numerico da inserire in una prescrizione. È un processo complesso, che richiede ascolto, osservazione, metodo e capacità di integrare test oggettivi e soggettivi con una valutazione personalizzata.
Solo così il professionista può garantire al paziente non solo una visione nitida, ma anche un miglioramento del benessere generale.
L’aggiornamento continuo e l’adozione consapevole delle nuove tecnologie rimangono strumenti indispensabili per affrontare le sfide della pratica clinica moderna e rispondere alle esigenze di pazienti sempre più attenti alla propria salute visiva.
Il contenuto di questo articolo è tratto dalla lezione ECM “Gli step per un esame refrattivo efficace”, curata dal Dott. Davide Vaglia (Ortottista assistente di oftalmologia – ASST Rhodense). Il materiale originale fa parte del Percorso Formativo Professione Oculista 2025. I contenuti sono utilizzati con finalità divulgative e restano di proprietà dei rispettivi autori.
Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento, è possibile acquistare la lezione completa all’interno del Percorso Formativo ECM 2025, accedendo così a contenuti più dettagliati e specifici.
Sei Medico Oculista oppure Ortottista? Iscriviti subito al Percorso Formativo Professione Oculista un programma completo pensato per Medici Oculisti e Ortottisti. Il corso affronta numerosi argomenti, dalla neuro-oftalmologia alla chirurgia refrattiva, dalla gestione delle patologie retiniche alle tecniche ortottiche avanzate.
12 lezioni | 36 crediti ECM
Scopri il programma completo su www.professioneoculista.it