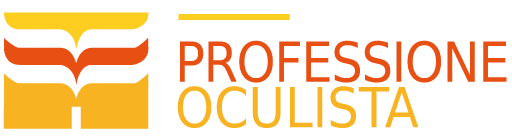Palpebre e superficie oculare: un equilibrio delicato
Patologie palpebrali. Le palpebre sono molto più che un “coperchio” protettivo:
regolano la distribuzione del film lacrimale, difendono la superficie oculare e tengono in equilibrio l’interfaccia tra cute e congiuntiva.
Comprenderne l’architettura — tarso, setto, legamenti, orbicolare, elevatore e muscolo di Müller — aiuta a leggere correttamente i segni clinici e a scegliere l’intervento giusto al momento giusto.
La micro-anatomia del margine (ciglia, ghiandole di Zeiss e di Moll) e il ruolo delle ghiandole di Meibomio, che forniscono la componente lipidica del film lacrimale, spiegano perché un’alterazione strutturale si traduca spesso in instabilità di superficie e sintomi irritativi.
Ptosi: quando la palpebra che scende chiede una diagnosi funzionale
La ptosi palpebrale può presentarsi a tutte le età, come forma congenita o acquisita, e porta con sé domande pratiche: quanto è “pesante”, quanto “lavora” l’elevatore, c’è rischio per la funzione visiva?
La valutazione non si limita alla misura della caduta, ma considera in modo sistematico la funzione dell’elevatore (normale oltre 8 mm, intermedia tra 4 e 8 mm, scarsa sotto 4 mm), l’eventuale lid-lag e i segni che fanno sospettare cause miogene, neurogene o aponeurotiche.
Il test alla fenilefrina mantiene un valore decisivo:
la risposta del muscolo di Müller orienta verso plicature/resezioni transcongiuntivali nelle ptosi minime, mentre la scarsa funzione dell’elevatore spinge alla sospensione frontale, che “recluta” l’azione del frontale per sollevare la palpebra.
Nel bambino la regola è proteggere lo sviluppo visivo: se la ptosi monolaterale condiziona ambliopia o postura viziata del capo, l’intervento precoce è da preferire; nelle forme acquisite post-traumatiche o neurogene, attendere la stabilizzazione clinica può evitare revisioni inutili.
La chirurgia dell’elevatore, eseguita in anestesia locale quando possibile, consente di modulare in diretta il risultato; tra le complicanze da prevenire e gestire: ipo/sovracorrezione, lagoftalmo con cheratite da esposizione, emorragia in pazienti anticoagulati.
Malposizioni del margine: tra trichiasi, entropion ed ectropion
La trichiasi è un problema “piccolo” solo in apparenza: ciglia deviate verso cornea e congiuntiva causano dolore, fotofobia e danno epiteliale; l’epilazione dà sollievo, ma la stabilità passa da laser/elettrolisi o da correzioni chirurgiche dedicate (ad esempio rotazione tarsale segmentaria).
L’entropion porta il margine “dentro”, con sfregamento cronico delle ciglia; riconoscerne la causa – congenita, cicatriziale, spastica, meccanica o senile – cambia la terapia.
La visita in lampada a fessura, la ricerca di retrazioni o aderenze e i test di statica palpebrale guidano un percorso che può includere protezione di superficie con sostituti lacrimali e pomate, tossina botulinica nelle forme spastiche e, soprattutto, chirurgia etiologica: tensionare la lassità orizzontale (cantopessia), ridurre lo “scivolamento” dell’orbicolare e riposizionare i retrattori con blefarotomie mirate.
All’opposto, l’ectropion espone la congiuntiva e altera il drenaggio lacrimale. Nelle forme involutive il difetto è spesso una “somma” di lassità verticali e orizzontali: correggerle in modo combinato (riposizionamento dei retrattori, accorciamenti orizzontali, cantopessie) ripristina apposizione al bulbo e comfort.
Nelle forme paralitiche, la protezione della cornea è prioritaria; nei casi stabili, la chirurgia affronta sia l’ectropion inferiore sia il lagoftalmo superiore (fino al posizionamento di un peso d’oro), mentre nelle forme cicatriziali da ustioni o traumi la ricostruzione a step è spesso necessaria.
Tumori palpebrali: dall’occhio clinico alla radicalità oncologica
Le palpebre ospitano un repertorio ampio di lesioni: cheratosi seborroiche, papillomi, cisti e il mollusco contagioso tra le benigne; ma quando si entra nel terreno dei tumori maligni la priorità è la radicalità chirurgica con margini adeguati e la corretta stadiazione.
Il carcinoma basocellulare è nettamente il più frequente (quota largamente maggioritaria dei maligni), tipico della palpebra inferiore e sostenuto da esposizione UV e suscettibilità genetica. I sottotipi nodulare, superficiale, infiltrativo e micronodulare hanno comportamento diverso e influenzano le scelte terapeutiche.
La chirurgia rimane lo standard (margini di 5–10 mm), con radioterapia nei non operabili e opzioni sistemiche mirate alla via di segnalazione Hedgehog nei casi selezionati.
Il carcinoma squamocellulare richiede maggiore attenzione per il rischio metastatico e indica exeresi più ampia; il carcinoma sebaceo, spesso confuso inizialmente con un calazio, è aggressivo e recidivante, e il trattamento associa asportazione a mitomicina topica quando indicato.
Infine, linfomi MALT e rari melanomi palpebrali impongono percorsi multidisciplinari con onco-ematologi e anatomopatologi.
La buona pratica clinica, in ogni caso, parte da una biopsia/escissione diagnostico-terapeutica correttamente pianificata e da una ricostruzione che rispetti statica e dinamica palpebrale per minimizzare trichiasi, malposizioni e danni di superficie nel follow-up.
Dalla visita alla sala operatoria: continuità e scelte condivise per la gestione delle patologie palpebrali
Al di là delle singole patologie, il filo rosso è un percorso decisionale coerente:
- anamnesi mirata (fotodocumentazione, terapia in atto, comorbilità)
- esame obiettivo con attenzione a statica/dinamica
- stratificazione dei rischi (occhio secco, portatori di LAC, anticoagulanti)
- definizione partecipata degli obiettivi funzionali ed estetici
Nella ptosi dell’adulto l’accurata selezione tra resezione dell’elevatore, approccio sul Müller o sospensione frontale migliora stabilità e soddisfazione; nelle malposizioni il risultato migliore arriva dalla correzione “a misura di patogenesi”; in oncologia palpebrale la radicalità onco-chirurgica, integrata quando serve da radioterapia o terapie mirate, fa la differenza sugli esiti a lungo termine.
Patologie palpebrali: dall’anatomia alla scelta terapeutica
In definitiva, le patologie palpebrali chiedono uno sguardo clinico che unisca anatomia, funzione e priorità terapeutiche.
La corretta lettura della statica e della dinamica palpebrale consente di distinguere ciò che è urgente (protezione della superficie oculare, rischio ambliopico, sospetto oncologico) da ciò che può essere pianificato con maggiore calma.
Nella ptosi, la misura della funzione dell’elevatore e la risposta del muscolo di Müller guidano scelte chirurgiche realmente personalizzate; nelle malposizioni, l’efficacia nasce da una correzione etiologica e combinata più che da soluzioni temporanee.
In oncologia palpebrale, la radicalità adeguata resta il cardine, integrata quando serve da ricostruzioni rispettose della biomeccanica e da percorsi multidisciplinari.
Il risultato migliore non è solo estetico: è un margine stabile, una superficie oculare protetta e una visione preservata.
Condividere obiettivi e timing con il paziente – spiegando rischi, benefici e possibili revisioni – rende il percorso più sicuro e prevedibile, trasformando la diagnosi in una decisione terapeutica chiara e proporzionata.
Il contenuto di questo articolo è tratto dalla lezione ECM “Patologie palpebrali”, curata dal Dott. Mauro Cassinerio (ex Dirigente Responsabile U.S.C. Oculistica ASST-Rhodense). Il materiale originale fa parte del Percorso Formativo Professione Oculista 2025. I contenuti sono utilizzati con finalità divulgative e restano di proprietà dei rispettivi autori.
Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento, è possibile acquistare la lezione completa all’interno del Percorso Formativo ECM 2025, per accedere a contenuti più dettagliati e specifici.
Sei Medico Oculista oppure Ortottista? Iscriviti subito al Percorso Formativo Professione Oculista un programma completo pensato per Medici Oculisti e Ortottisti. Il corso affronta numerosi argomenti, dalla neuro-oftalmologia alla chirurgia refrattiva, dalla gestione delle patologie retiniche alle tecniche ortottiche avanzate.
12 lezioni | 36 crediti ECM
Scopri il programma completo su www.professioneoculista.it